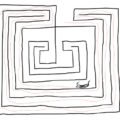Piaccia o non piaccia, il teatro di ricci/forte in questi anni ha creato uno stile personale. Che però con “Darling” non riesce proprio a toccarti dentro. Un paio d’ore di azioni concitate e di parole a ruota libera sono scorse via senza lasciare traccia – Renato Palazzi
Con tutto il rispetto per Ricci/Forte, che – piaccia o non piaccia il loro teatro – in questi anni hanno sempre fatto quello che dovevano fare, né di più né di meno, conquistando un pubblico di fedelissimi, imponendo un proprio stile con astuzia ma anche con qualche guizzo di provocazione vera, mi sembra di poter dire che questo Darling approdato ora a Milano sia uno spettacolo sbagliato. Si può capire che il richiamo all’Orestea, da cui il duo è partito, sia del tutto pretestuoso: è il minimo che ci aspettiamo da loro. Si può capire che il disordine, lo smarrimento contemporaneo non possano essere resi che attraverso un disordine, uno smarrimento linguistico. Ma qualcosa, a chi è venuto a vederti, un graffio, una piccola vibrazione nervosa la devi pur dare: invece quel paio d’ore di azioni concitate e di parole a ruota libera sono scorse via senza lasciare traccia.
La formula Ricci/Forte si basa stavolta su un testo composito, che alterna norme di corretto comportamento a tavola a riferimenti classici e a scorci autobiografici degli attori, dove gli accenni alle uccisioni di Agamennone e Cassandra, di Egisto e Clitennestra restano sullo sfondo come casi di odierna cronaca nera. La trama espressiva, confusa, frammentaria, mescola chiavi diverse, mani guantate usate come burattini e balletti di impronta vagamente televisiva, immagini di naufraghi, di reduci da un’apocalisse e lunghi monologhi privi di senso, il tutto scandito da musiche per lo più insulse e stucchevoli. L’impianto scenografico è incentrato su una baracca di metallo, una specie di container che diventa reggia, prigione, stanza degli orrori, e che via via gli attori smontano e rimontano, su cui camminano, a cui si appendono. Tutto questo, però, in ordine sparso, senza un filo conduttore.
Che senso ha, per Ricci/Forte, il riferimento all’Orestea? Da quanto si coglie dalle loro dichiarazioni, la tragedia eschilea li ha attratti – se non ho male inteso – soprattutto per il tema finale dell’istituzione di un tribunale democratico, in cui l’atto matricida di Oreste si risolve non in vendetta tribale ma in ponderato giudizio della polis: cosa resta, sembrano chiedersi i due autori, di quell’ideale di pacifica convivenza, di civile risoluzione delle controversie tra individui in nome di più alti valori collettivi, in un mondo plastificato, ridotto a vetrina, dove si è soffocata l’animalità dell’uomo solo per ingabbiarla in stanchi riti di consumo? Non rimane che un arido galateo di comportamenti in società – parrebbe essere la loro risposta – una ossessiva serie di prescrizioni di buona educazione, dove le regole sull’uso delle posate sostituiscono il sogno di un’evoluzione della specie.
Questa visione apocalittica della realtà in cui viviamo, gabellata per sentimento generazionale, è invece – a mio avviso – a sua volta plastificata, buona per tutti gli usi come i fari sparati in faccia agli spettatori, come le tute arancioni da prigionieri di Guantanamo: un imprecisato rifiuto dell’oggi che diventa luogo comune, mero contenitore, freddo oggetto di spettacolo. Ma, al di là delle considerazioni sul Ricci/Forte-pensiero, mi è parso che altrettanto imprecisato, generico, asettico risultasse questo loro modo di esprimere il rifiuto. Senza pretendere una chiara costruzione drammaturgica, va pur detto che Darling è una sequenza sfilacciata di situazioni, di gesti, di rumori, di citazioni che potrebbero applicarsi a qualunque testo, a qualunque tema. Che qui si tratti del decadere di un’utopia democratica, lo apprendiamo dai programmi di sala, non da ciò che accade alla ribalta.
Lo spettacolo ha due momenti in qualche modo attinenti alla materia: l’inizio, con quella figura femminile in nero abito settecentesco, l’enorme parrucca bianca e la bianca maschera in disfacimento sul volto, che farfuglia i suoi oscuri vaticini dall’alto del container, e non si sa se sia una dea, una regina o un oracolo, se sia Cassandra o Clitennestra, e il finale, con una quantità di sinistri bambolotti di plastica infilati e come affogati dentro dei secchi bianchi allineati lungo il proscenio. Fra questi due poli di energia, tuttavia, c’è solo un agitarsi senza sviluppo, un magma incerto di comportamenti, di corpi, di suoni che neppure per un attimo ti tocca dentro, ti comunica un’ombra di emozione. E certo non aiuta l’infelice dislocazione spaziale, con un grande vuoto fra attori e spettatori, che attutisce le sensazioni e disperde le voci, rendendo faticosa la percezione delle singole parole.
Se mi soffermo su questo spettacolo a oltre un anno dal suo debutto, avvenuto nell’ottobre 2014 al Festival Romaeuropa, è anche perché fa un po’ specie vederlo inserito nella stagione del più importante teatro nazionale. Uno spettacolo non riuscito, in un percorso artistico, può capitare, ma perché sceglierlo a mente fredda, anche dopo l’uscita di recensioni non proprio positive, col rischio di bruciare una politica di rinnovamento? Nessuno è andato a vederlo prima di prenderlo? Di sicuro la platea del Teatro Studio, che pure ama i «dioscuri della scena italiana», come il Piccolo li definisce, non ha gradito, e alla “prima”, fra applausi di cortesia, non ha fatto mancare qualche reazione meno cortese.
Visto a Milano, Teatro Studio Melato, fino al 7 febbraio
Darling (ipotesi per un’Orestea)
drammaturgia Ricci/Forte
regia: Stefano Ricci
elementi scenici: Francesco Ghisu
costumi: Gianluca Falaschi
movimenti: Marco Angelilli
suono: Thomas Giorgi
con: Anna Gualdo, Giuseppe Sartori, Piersten Leirom, Gabriel Da Costa